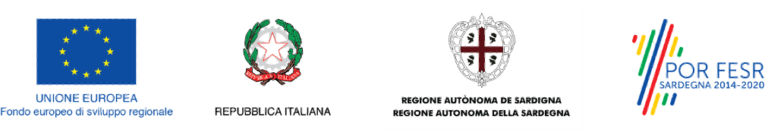Il gruppo carbossilico è uno degli argomenti di base di chimica, sia alle scuole superiori che nei quiz di chimica presenti nei test di ammissione alle facoltà ad accesso programmato.
In questo articolo ti spieghiamo cos’è il gruppo carbossilico, le sue caratteristiche e cosa sono gli acidi carbossilici, per aiutarti a superare a pieni voti compiti in classe, interrogazioni e test di medicina, veterinaria e professioni sanitarie.
Gruppo carbossilico
Cos’è il gruppo carbossilico?
Il gruppo carbossilico è formato dal gruppo carbonilico, C=O, e dal gruppo ossidrilico, -OH.
Le proprietà chimiche del gruppo carbossilico sono:
- la formula del gruppo carbossilico è -COOH
- è legato a residui alchilici o arilici
- ha angoli di legame di circa 120°
- ha ibridazione sp2
- è planare

Acidi carbossilici
Il gruppo carbossilico è il gruppo caratteristico degli acidi carbossilici.
Infatti, gli acidi carbossilici, detti anche acidi organici, contengono il gruppo carbossilico.
I legami degli acidi carbossilici determinano la tipologia di acido carbossilico:
- aromatico, se il gruppo carbossilico è legato a un anello benzenico
- alifatico, se il gruppo carbossilico è legato a un radicale alifatico
Le caratteristiche degli acidi carbossilici sono:
- gli acidi carbossilici sono polari e formano legami idrogeno sia con altre molecole sia da sé, donando o ricevendo;
- hanno un elevato punto di ebollizione, proprio a causa dei legami idrogeno;
- hanno solubilità pari o maggiore a quella dei corrispettivi alcoli;
- hanno un comportamento acido debole.
Un esempio è l’acido acetico CH3COOH con Ka =1.74 · 10-5’. L’acidità degli acidi carbossilici aumenta, se al carbonio legato al gruppo carbossilico, si definisce carbonio α, è sostituito un atomo o un gruppo di atomi di elettronegatività maggiore.
pKa crescente CH3COOH (4,76) < ClCH2COOH (2,86) < Cl3CCOOH (0,76)
In grassetto è mostrato il carbonio α.
Per ripassare, leggi anche: La solubilità: cos’è e da cosa dipende e I legami chimici: cosa sono, elenco ed esempi.
Acidi carbossilici: nomenclatura
Alcuni acidi carbossilici hanno un nome comune che deriva dalla fonte in cui sono stati scoperti.
Invece, la nomenclatura IUPAC degli acidi carbossilici alifatici si ottiene dal:
- conteggio degli atomi di carbonio
- prefisso relativo all’alcano
- suffisso -oico, per gli acidi monocarbossilici e -dioico, per gli acidi dicarbossilici
Ad esempio, l’acido capronico o acido esanoico secondo la nomenclatura IUPAC si trova nel grasso della capra e ha formula molecolare CH3(CH2)4COOH. Ed è anche una delle cause della puzza di sudore!
Per quanto riguarda la nomenclatura IUPAC, il gruppo -COOH ha priorità sulla maggior parte dei gruppi funzionali, compresi i carbonilici di chetoni e aldeidi, i gruppi ossidrilici e amminici.
Acidi carbossilici: reazioni
Le reazioni tipiche degli acidi carbossilici sono reazioni di sostituzione. Durante queste reazioni di sostituzione, il gruppo idrossile viene sostituito con altri gruppi. Dalle reazioni di sostituzione si originano ammidi, esteri, anidridi e non solo.
In presenza di acidi carbossilici si possono verificare queste reazioni:
- la disidratazione e la conseguente formazione di anidride organica;
- la reazione con una base che porta alla formazione di un sale, l’anione carbossilato;
- l’attacco al carbonio dello ione carbossilato, originato dalla salificazione di cui al punto precedente;
- una reazione di esterificazione di Fischer, se il carbonio carbonilico subisce un attacco nucleofilo;
- la decarbossilazione, se l’acido carbossilico perde una molecola di CO2.
Il gruppo carbossilico è un gruppo funzionale molto resistente alla reazione di riduzione; per fare ciò è necessario l’utilizzo di un forte agente riducente, il litio alluminio idruro, che riduce il gruppo carbossilico ad alcoli primari.
I corpi chetonici sono delle molecole organiche che presentano il gruppo carbossilico. Nello specifico, l’acido acetoacetico e il suo prodotto di riduzione acido 3-idrossibutanoico, sono sintetizzati nel fegato.
Quante volte da bambino ti hanno detto di stare attento a non mangiare troppe “schifezze” o di non stare senza mangiare? Infatti, l’abuso di cibi grassi o i digiuni prolungati possono generare una concentrazione di corpi chetonici molto elevata nel nostro corpo. Questo porta ad una loro decarbossilazione spontanea ad acetone e anidride carbonica. L’acetone non è metabolizzato dal nostro corpo ed è la causa del caratteristico “odore dolce” dell’alito di questi bambini.
Sogni di superare il test medicina, odontoiatria, veterinaria e professioni sanitarie? L’offerta WAU! comprende più tipi di corsi per ogni esigenza: con partenza mensile, intensivi, biennali, on demand.
I nostri corsi, pensati per darti la massima preparazione per il nuovo TOLC-Medicina, includono teoria, pratica, piattaforma e-learning con simulatore.
Scopri tutti i vantaggi dei corsi WAU!: il supporto dello Student Care WAU!, l’esperienza decennale di tutor e docenti, i pagamenti dilazionati. E se non passi il test, accedi a “ammesso o ripreparato”.
Immagine in evidenza di Chokniti Khongchum da Pexels